Oggi sono in città.
Il lavoro di ricerca all'Archivio di Stato è impegnativo, ma
io sono pronto: ho con me un collaboratore di prim'ordine e ci dividiamo i
compiti.
Fogli matricolari, documenti del Gabinetto di Prefettura
sulle inaugurazioni dei monumenti ai caduti nella Valle del Sele, un bel saggio
storico che ricostruisce le vicende di alcuni monumenti nella provincia di
Salerno.
Sono soddisfatto della mattinata di ricerche e anche del pranzo.
E' ora di prendere il pullman, bisogna procedere verso la fermata.
All'improvviso, mi fermo.
La vedo.
Non credo ai miei occhi.
Se non ci fosse un'auto parcheggiata un po' così, scatterei delle foto migliori, per far vedere che alle spalle del monumento c'è la stazione ferroviaria.
Davanti al monumento ai Caduti di tutta la provincia, c'è una porta.
Penso subito a un'installazione di arte postmoderna: una
porta qui, una sedia e un cesso di là, e chi non capisce vuol dire che non si
intende d'arte e allora si occupi d'altro, torni al paese.
Lo confesso: cerco in internet qualche informazione.
Non mi sorprende nulla, ormai; magari leggo che è stata
inaugurata -tra fotografi in estasi e giornalisti festanti, come vedo sempre
più spesso in giro per l'Italia- una nuova attrazione, dal titolo suggestivo e
poetico (mi sembra di prevedere il lessico di alcuni devoti cronisti): La
porta della memoria.
Però non trovo nulla e allora mi convinco che quella porta
che è qui, davanti a me -e soprattutto davanti al monumento che ricorda il
sacrificio di migliaia di soldati di tutta la provincia- è una porta priva di
parete, uno scheletro di porta, senza significato.
Reagisco in maniera un po' concitata, ma forse ho difetti
peggiori.
Mando le foto al sindaco, su Facebook.
So bene che non deve certo occuparsi lui di rimuovere i
rifiuti dalla strada e che non può sapere tutto quello che succede in tempo
reale nella sua città.
Però quando sono indignato ho bisogno di fare un po' di
"ammuina", altrimenti finisco col firmare appelli o partecipare a
convegni (non merito questo).
Ritengo importante attirare l'attenzione su un aspetto di
decoro urbano e di rispetto per la memoria storica.
Una risposta preimpostata mi dice: "Siamo grati per
averci scritto". Io ribatto che invece non sono grato per come viene
tutelata "la memoria anche dei miei Caduti in guerra".
Caspita, qui ci sono anche i miei caduti in guerra, quelli
di cui mi occupo da oltre tre anni, le cui tracce cerco nella polvere
dell'Archivio di Stato o nei cimiteri e nei sacrari del Veneto.
Proprio nella polvere dell'Archivio di Stato, stamattina ho
scoperto che alcuni miei concittadini (e chissà quanti altri in tutta Italia)
hanno combattuto sia la Prima sia la Seconda guerra mondiale.
Altri, magari ventenni, dalla Prima non sono tornati.
Alcuni di loro erano troppo giovani per sposarsi senza il
consenso dei genitori, ma evidentemente abbastanza grandi per diventare carne
da cannone.
Il saggio sui monumenti della provincia, consultato stamattina, ha un titolo significativo: La memoria degli assenti.
Un titolo che mi piace interpretare come bivalente.
Come al liceo: il genitivo può essere soggettivo oppure oggettivo.
La memoria che hanno le persone assenti.
Ma quale memoria possono avere i morti?
La loro memoria è sospesa, non è mai diventata racconto.
Eppure sappiamo che essi parlano. Il poeta ci invita a cessare di ucciderli e a iniziare ad ascoltarli: hanno una voce che è un "impercettibile sussurro", essi "non fanno più rumore del crescere dell'erba".
Se hanno una voce, gli assenti hanno anche una memoria alla quale attingere, per poter raccontare a noi.
Ma la memoria degli assenti può anche significare la memoria che abbiamo noi dei morti: è quella che coltiviamo noi, ricordando gli assenti, onorando i caduti.
E' una memoria pubblica, civile. Ecco che un monumento, un sacrario, una semplice lapide servono a rendere concreta questa memoria. La memoria diventa istituzionalizzata.
Dopo la Grande Guerra, con un'enfasi e una retorica che oggi
a volte ci sembrano eccessive, i caduti sono stati celebrati come martiri.
A distanza di cento anni, abbiamo la possibilità di
trovare le parole giuste, per inquadrare il loro sacrificio nel preciso
contesto storico.
Possiamo essere loro grati anche se non usiamo più i toni
ferventi e patriottici degli anni Venti e io, nel mio piccolo, cerco di
raccontarne le vicende: non mi interessa che siano eroiche, mi interessa che
siano vicende di giovani che parlavano il mio dialetto e vivevano nei luoghi
che mi hanno visto nascere e sbucciarmi le ginocchia.
Poi qualcuno pensa di lasciare una porta davanti al
monumento dedicato a loro e a migliaia come loro...e allora non basta scriverlo
al sindaco, mi dico, occorre coinvolgere anche la polizia locale (incontro qualche
difficoltà, ma forse sbaglio io a inviare una mail con le foto in allegato:
quante cose scopro oggi), ma non mi accontento: contatto l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e mando le foto a un giornale
locale (dal quale ricevo un altro messaggio preimpostato).
Qualcuno prima o poi mi risponderà, o forse nessuno.
Non importa, non mi importa leggere "abbiamo
provveduto" o "grazie per la segnalazione".
A me interessa che qualcuno tolga quella porta.
Poi vorrei capire, se non chiedo troppo, cosa ci faceva lì.
Poi vorrei capire, ma ora temo di chiedere davvero troppo,
come ci siamo ridotti.
G.V.



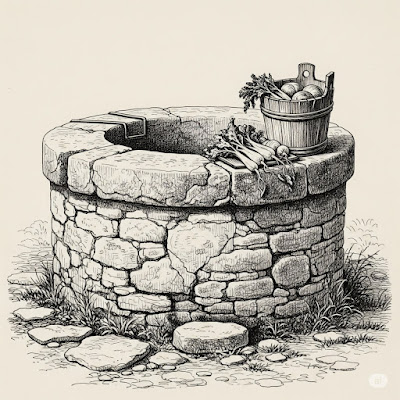















.jpg)
.jpg)
.jpg)






