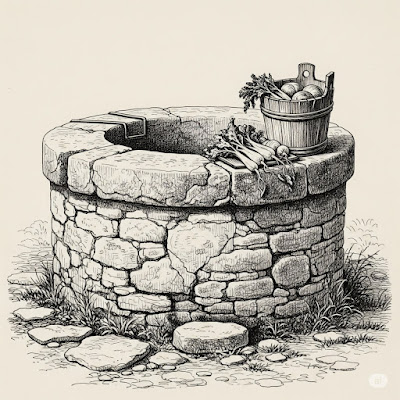.jpg) |
| Padova, Museo nazionale dell'Internamento; fonte |
 |
| L'onorevole Giorgio Mulè |
Ho detto sempre “no”. Sono stato due anni a dire sempre “no”. Ci trattavano come traditori, ci comandavano a bastonate dalla mattina alla sera, tutti i mezzi erano buoni per abbatterci. Ho fatto la Resistenza più che la prigionia. Mi sono sempre sentito resistente. Il mio più grande amore è l'Italia.Mulè ha infine concluso il suo intervento affermando: "Scusate il ritardo. Con questa legge l'Italia si inchina all'esempio e al sacrificio dei 650.000 soldati".
Boschi ha sottolineato la lezione morale da trarne:
Io credo che giornate come questa ci tengano dritta la barra sui valori autentici su cui abbiamo fondato la nostra Repubblica.Il valore morale del rifiuto
L’onorevole Pino Bicchielli (Noi Moderati) ha affermato:
Ci sono atti, nella storia di una Repubblica, che meritano di essere ricordati quanto quelli di chi, alla propria stessa vita, antepone il rifiuto ad assoggettarsi all'occupazione straniera. Vi è in esso il senso stesso della patria, della fedeltà ad essa e della libertà di comunità che si rivendica, pur sapendo di perdere quella personale.Per l’onorevole Marco Pellegrini (M5S) è importante specificare la motivazione del rifiuto:
La precisazione inequivocabile che sancisce e afferma in maniera netta che i militari italiani furono deportati e internati perché si rifiutarono di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica Sociale Italiana, con i fascisti della Repubblica Sociale Italiana.
L’ onorevole Andrea De Maria (Partito Democratico) ha ribadito l'unità delle diverse forme di Resistenza:
Il fatto che la scelta degli internati militari italiani fu
una scelta di resistenza e che, quindi, c'è un'unità nelle diverse forme di
resistenza: quella armata nel Paese, i civili che sostennero i partigiani,
appunto, la scelta che fecero gli internati militari italiani.
Il ruolo della società civile e delle associazioni L’ onorevole Laura Cavandoli (Lega) ha riconosciuto il ruolo delle associazioni:
Associazioni che ci hanno preceduto e ci hanno stimolato per
questa proposta legislativa, hanno fatto da guida, essendo già attive da tempo
nella promozione per la diffusione di questi alti valori che hanno ispirato i
nostri predecessori, che ancora oggi possiamo chiamare eroi o anche martiri.
Questo dibattito in Aula ha avuto luogo tra il 16 e il 19
settembre 2024, quando c’è stata la votazione finale: 256 favorevoli su 256
votanti.Nella seduta n. 259 del giorno 8 gennaio 2025, in Senato c’è stata l’approvazione definitiva del disegno di legge.
Nel corso del dibattito finale, la senatrice Petrenga -relatrice- ha evidenziato l'obiettivo di
conoscenza del valore storico, militare e morale della vicenda degli internati e di ricordo delle sofferenze da loro patite in violazione di tutte le leggi di guerra e dei diritti inalienabili della persona, nonché quale messaggio di pace rivolto alle giovani generazioni.La senatrice Raffaella Paita (Italia Viva) ha definito l’iniziativa “giusta e opportuna” e ha concluso sottolineando l'unità dell'Aula:
Questa è una bellissima giornata perché... oggi potremo essere tutti uniti nel riconoscere una centralità anche a queste persone e per restituire loro dignità e orgoglio.
Il senatore Zanettin (Forza Italia) ha ricordato l’amaro dopoguerra degli IMI:
Il rientro a casa degli IMI fu estremamente complicato per
la mancanza di un efficace coordinamento da parte dello Stato italiano" e
come la loro tragedia fosse stata "interpretata, nel migliore dei casi,
come sfortunato corollario della guerra o letta come prova di vigliaccheria e rifiuto di
combattere.
Il senatore Paganella (Lega) ha messo in luce la
marginalità vissuta da questi soldati –“veri e propri eroi della Resistenza”-
nel secondo dopoguerra, quando che si sentirono "emarginati, messi da
parte, considerati quasi rappresentanti di una Resistenza di serie B".Ha inoltre messo in luce la scelta di coscienza degli internati italiani:
I combattenti italiani si erano trovati senza una guida, soli
davanti alla loro coscienza" e che seppero "conservare la dignità
anche in un momento altamente drammatico della storia nazionale.
Il senatore Lucio Malan (FdI) ha condiviso il ricordo del padre
internato. Si è soffermato sulle condizioni degli internati, costretti al lavoro coatto, minacciati, malnutriti e alloggiati in luoghi inadeguati.La loro fu una forma silenziosa ma concreta di Resistenza: scelsero di non aderire alla Repubblica Sociale Italiana né di collaborare con il regime nazista, pagando un prezzo altissimo per difendere la propria dignità.
Ora questa legge rimedia all’oblio al quale queste centinaia di migliaia di italiani erano stati sottoposti.
Il senatore Marton (M5S) ha utilizzato un’immagine potente:
La loro resistenza silenziosa è un seme piantato nel terreno
della democrazia e della libertà che noi oggi continuiamo a coltivare.
Ha concluso con un monito per le future generazioni:Non dimentichiamo che la storia si ripete solo quando si
perde la memoria. Non dimentichiamo che la libertà non è mai scontata. Non
dimentichiamo che ognuno di noi, oggi come allora, può essere chiamato a
scegliere tra il giusto e il comodo.
La Resistenza in tutte le sue formeCome aveva fatto alla Camera il suo collega De Maria, il senatore Dario Parrini (PD) ha proposto il concetto di “tante resistenze”:
Quella in armi dei partigiani, quella silenziosa e
coraggiosissima di tantissimi cittadini... la Resistenza degli IMI che, senza
armi, hanno detto no alla collaborazione con Hitler e Mussolini.
Parrini ha inoltre rimarcato la complementarietà della
Giornata del 20 settembre con il Giorno della Memoria (27 gennaio) e la Festa
della Liberazione (25 aprile), vedendola come "un evento simbolo di una
delle tante forme di Resistenza al nazifascismo".A ottant’anni dal loro rientro – per chi è riuscito a tornare – il “No” di 650.000 soldati italiani è diventato un “Sì” della Repubblica.
Il Parlamento ha riconosciuto il valore di quel rifiuto: un atto di Resistenza, una scelta morale.
Ora la memoria è legge e la legge un impegno per il futuro.
Camera: Resoconto stenografico dell'Assemblea. Seduta n. 350 di giovedì 19 settembre 2025
Senato: Resoconto stenografico della seduta n. 259 del 08/01/2025
Sulla legge 6/25 abbiamo pubblicato due post:
👉I venticinque anni della legge sul "Giorno della Memoria": un confronto con la legge sugli Imi
👉20 settembre, la Giornata degli Internati Militari
.jpg)

.jpeg)